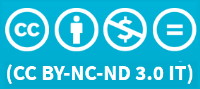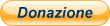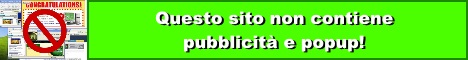Descrizione: Breve discorso sulla neutralità della tecnica.
Incipit: L'assunto "I problemi non li crea la scienza, ma l'uso che l'uomo ne fa" sembra del tutto innocuo, c…
1° in opere commentate (Medio, dal 2020)
1° in opere commentate (Medio, dal 2019)
1° in opere commentate (Medio, dal 2018)
1° in opere commentate (Medio, dal 2017)
1° in opere commentate (Medio, dal 2016)
1° in opere commentate (Medio, dal 2015)
1° in opere commentate (Medio, dal 2014)
1° in opere commentate (Medio, dal 2013)
1° in opere commentate (Medio, dal 2012)
1° in opere commentate (Medio, dal 2011)
1° in opere commentate (Medio, dal 2010)
1° in opere commentate (Medio, dal 2009)
1° in opere commentate (Medio, dal 2008)
1° in opere commentate (Medio, dal 2007)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2021)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2020)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2019)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2018)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2017)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2016)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2015)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2014)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2013)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2012)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2011)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2010)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2009)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2008)
2° in opere commentate (Saggio, dal 2007)
Sicuramente al giorno d'oggi la condizione dell'umanità è come in "mezzo al guado": dietro, la sua storia disperata e drammatica e davanti, una serie di pericoli rischiosissimi, teorizzati e ben compresi nel suo futuro.
É vero che oggi siamo già schiavi della tecnica e della necessità di considerare la scienza come punto di riferimento assoluto, ma io credo che lo sia solo temporaneamente, fino a quando la tecnica sarà talmente evoluta e universalmente utilizzata (anche dalle masse) da elevare la vita degli uomini a vera esistenza.
Verrà il tempo in cui non ci sarà più bisogno di accumulare perché tutto sarà disponibile e ci sarà tempo per pensare.
In quel Paradiso della Tecnica l'Uomo avrà altre ambizioni.
"La tecnica, il fare, sembra precedere dunque l'intelligenza umana (e non viceversa); non è un punto da poco."
Il controllo del fuoco (già esistente in natura) è la tecnica che l'uomo ha imparato e poi usato e poi evoluto con l'intelligenza, a sua volta accresciuta dall'esperienza stessa in una interdipendenza assoluta.
L'uomo non poteva restare nudo, pena la sua estinzione.
Ma, secondo me, Non "È possibile affermare che la tecnica sia la Vera Essenza dell'Uomo anche se attraverso di essa egli propone la sua signoria sul mondo".
Vero è che con la scienza moderna "Non solo la Natura da soggetto diventa oggetto, ma anche l'Essere umano da soggetto si trasforma in oggetto." Perché " il modo formalmente più razionale di esercitare il potere è la razionalità tecnica". L'Apparato non è costituito solo da concettualità scientifica e strumentazione tecnologica, ma anche da un sistema di condizioni economiche, giuridiche, politiche, burocratiche, urbanistiche, sanitarie, scolastiche, militari, che consentono all'Apparato stesso di potersi esprimere e funzionare.
L'uomo si trova in mezzo al guado tra la Scienza moderna, che ha trasformato l'Uomo da soggetto in oggetto, in un fondo a disposizione (questa trasposizione di fini ha reso inefficace e inutile ogni antico sapere, ogni religione, etica, politica, filosofia); e oggi il capitalismo, fin che resisterà.
Ma verrà il tempo in cui non ci sarà più bisogno di accumulare perché tutto sarà disponibile e ci sarà tempo per pensare.
In quel Paradiso della Tecnica l'Uomo avrà altre ambizioni, perché sarà un uomo diverso avendo abbandonato ogni antico sapere. Probabilmente sarà pura consapevolezza di sé, senza corpo, inserito in un fluido meccanismo quantistico da dove potrà pensare a come finalmente spodestare Dio.
Farneticazioni fantascientifiche?
Non si trattava certo un rimbrotto rivolto a te, piuttosto a me, alla mia voglia di accorciare le distanze e cercare sintesi improbabili. Perdona il mio apparire brusco, se così l'hai percepito.
La tua seconda risposta, quella fantascientifica, è più antica di quanto tu non creda. Provo a correre (e a semplificare). La dicotomia tra corpo e mente, quel pensare che la mente possa sbarazzarsi del corpo e che essa solo sia nobile mentre il corpo è un antico retaggio di cui liberarsi, trae origine in modo ordinato e strutturato dalla metafisica platonica.
Con Platone Corpo e Mente si dividono. Con Platone nasce la Metafisica e l'idea di Dio come la concepiamo anche noi contemporanei.
Col neoplatonismo questa dicotomia è entrata poi definitivamente dentro al cristianesimo e alla tradizione giudaico cristiana dove ha assunto i connotati che tutti conosciamo e a cui non possiamo fare a meno di pensare quando pensiamo con la dicotomia corpo anima (totalmente sconosciuta all'ebraismo precristiano) che ricalca, semplifico, quella corpo mente.
Tale dicotomia si è trasferita pari pari nell'epistemologia, ossia nella scienza moderna.
Per questo tu sei indotto a pensare fantascientificamente in un Paradiso dove il corpo, come il corpo cristiano, non esiste più. Ma sussiste solo l'anima, o la mente del pensiero tecnico, scientifico, epistemologico. La scienza moderna è metafisica quanto il platonismo o il cristianesimo.
La dicotomia a mio avviso (nella filosofia detta esistenzialista che si riallaccia alla tradizione presocratica e preplatonica) è un paradigma errato. L'uomo è il suo corpo di cui la mente è parte integrante. L'uno non sussiste senza l'altro e viceversa. Un uomo senza il suo corpo semplicemente non è un Uomo, ma qualcos'altro.
Per tale motivo il Paradiso della Tecnica dove, come anche tu immagini, l'uomo si privi del corpo per diventare pura mente (quindi un dio precipitando di nuovo nella metafisica, cioè credendo a un Dio Artefice e facendo principiare ogni cosa da lì) è il luogo dove l'uomo diventa superfluo, dove l'uomo per cui è impossibile la dicotomia metafisica muore.
Ho violentato un secolo e mezzo di esistenzialismo. Ti consiglio la lettura di un testo di Galimberti, Il Corpo, che ben illustra con un linguaggio molto semplice i passaggi storici e filosofici che ci hanno portato a pensare il corpo e la mente come noi li pensiamo.
E quindi ad andare oltre, a cercare altre vie per proseguire quella già tracciata (sebbene fantascientifica) che sembra avere come unico e ultimo scopo il nichilismo e la morte dell'uomo.
E allora ti sono riconoscente per la generosità nell'impiegare il tuo tempo per rispondermi.
Dunque ho letto e capisco la tua posizione ma ho dubbi su cui lavorerò.
C'è una frase che mi ha colpito:
"La dicotomia a mio avviso (nella filosofia detta esistenzialista che si riallaccia alla tradizione presocratica e preplatonica) è un paradigma errato. L'uomo è il suo corpo di cui la mente è parte integrante. L'uno non sussiste senza l'altro e viceversa. Un uomo senza il suo corpo semplicemente non è un Uomo, ma qualcos'altro."
Proprio qualche settimana fa ho scritto sul sito una riflessione (Che ci facciamo qui?) nata da pensieri e ragionamenti che riguardano questo argomento.
Io non sono il mio corpo. E non sono neppure l'Individuo che fa muovere e che abita il mio corpo; questi ha le capacità mentali per organizzare la propria esistenza sia fisica che psicologica ed è in grado di avere coscienza di sé come forse anche altri animali.
Ma Io sono Altro: Io vedo tutto della mia persona e ne prendo consapevolezza.
IO non ho ancora capito chi siamo in realtà e che cosa ci facciamo qui, dentro questi corpi umani.
Quello che chiamiamo Uomo non è ancora definito.
La vita, intesa come vitalità, è proprio questo, interagire e nel farlo scoprire sempre nuovi orizzonti, ma sopratutto si adatta, muta e si trasforma continuamente obbedendo a una strategia affinata nel corso di ere geologiche. L'ambiente cambia e non sapendo in che direzione lo farà l'unica soluzione è tentare tutte le combinazioni possibili. Qualcuna trova terreno fertile e prospera, altre soccombono ma quel che resta sempre è la sua capacità di adattarsi e continuare a esistere.
L'uomo in se incarna solo una delle possibili scelte ma a guardare bene forse la migliore che la vita abbia fatto finora.
Non potendo adattarci al mondo lo cambiamo, lo sfruttiamo, come la vita ha sempre fatto perpetrando quell'atto di violenza iniziale.
Ora però abbiamo un vantaggio, possiamo definitivamente tirarci fuori, uscire da questo ambiente mutevole e creare la nostra terra dove vogliamo, forse per ora è ancora presto ma possiamo renderci conto della situazione e spezzare questa catena di violenza guardando al futuro.
Secondo me aldilà di ogni diversità dovremmo pensare all'uomo come razza da preservare dall'estinzione e solo la tecnologia può darci questo risultato, non il diventare più buoni e naturisti.
Per quanto mi riguarda cerco solo di interpretare la mia costante angoscia sul perché della mia vita.
E comunque sono gli scienziati stessi che ci stanno avvisando dei rischi che la tecnologia mal utilizzata può provocare. Rischi sui quali io scommetto per una soluzione positiva, ma solo perché a me piace pensarlo.
E se lo scopo fosse proprio quello di far "numero" portando avanti quella logica cui accennavo? Non ci sentiamo parte di una specie, ma se lo facessimo sarebbe tutto molto diverso.
Lo spettacolo sottomarino offerto dal comportamento della palla di sardine è meraviglioso.
Migliaia di individui si muovono in modo assolutamente sincronizzato dando forma al branco come se fosse un entità completa.
Ogni individuo ha ceduto la propria identità in favore dell'appartenenza al gruppo e si muove come se avesse chiara la motivazione della propria esistenza.
Ogni individuo si muove non in funzione del comportamento del vicino che può controllare, ma secondo una consapevolezza del "tutto" rappresentata dal gruppo completo: ogni individuo "sa" che cosa è la palla e si muove di conseguenza considerando la sua posizione, la velocità dello spostamento, e gli altri fattori che coinvolgono la palla stessa.
L'aspetto interessante e significativo è che il funzionamento di un simile meccanismo è per forza di logica basato su una comunicazione istantanea tra gli individui.
Che genere di trasmissione avviene tra le sardine perché possano muoversi in quel modo?
Che genere di trasmissione avviene tra i componenti di uno stormo di centinaia di uccelli, che hanno deciso tutti insieme le evoluzioni spettacolari prima di iniziare la migrazione?
Che genere di trasmissione avviene tra le singole, ma infinitamente numerose e diversificate, cellule che compongono un organo del corpo umano che permette all'organo stesso di essere un'entità differenziata, completa ed efficiente?
Come viene controllato che il codice genetico di ogni cellula si riproduca secondo il progetto?
Tutto è in vibrazione: si tratta della trasmissione di un'informazione che arriva a ogni singolo (cellula) per obbligarlo nella sua funzione o per informarlo del disegno complessivo lasciando al suo libero arbitrio la decisione.
Ogni cellula "sa" quale è il suo compito e si comporta di conseguenza; se decide di uscire dalla legge del suo corretto comportamento, avviene il cancro.
Nella natura pare che la regola generale sia quella dove l'ordine nei sistemi è l'unico mezzo per la realizzazione della vita in modo efficiente.
L'Uomo decide quale è l'ordine favorevole alla sua esistenza e decreta il bene e il male a seconda del vantaggio che può conseguire.
Non conosciamo un altro esempio di Essere dotato di libero arbitrio e leghiamo questa facoltà alla condizione di individualità: solo gli individui possono essere liberi di decidere le proprie scelte.
E l'individuo per essere libero deve avere coscienza di se stesso.
Posso anche immaginare di attribuire le facoltà umane a una singola sardina e posso immaginare che ogni sardina "decida" per libero arbitrio di comportarsi in modo sincronizzato nella palla di cui conosce la funzione.
Se gli uomini usassero il libero arbitrio in quel modo l'umanità sarebbe perfetta.
Nella cultura occidentale la negazione dell'individuo pare sia il maggior male possibile per l'Uomo.
Tutti gli studi sulla mente partono dal presupposto che si possa essere felici solo quando l'uomo avrà realizzato in modo completo la coscienza e la consapevolezza della sua individualità.
Ma forse la direzione è sbagliata!
Non è accentuando o rafforzando l'individualità, la Via per essere felici.
L'Eden non era altro che la fusione degli esseri in un unico Essere, e il Peccato Originale è stato determinato dalla presa di coscienza di sé stessi come individui?
Il distacco dell'individuo dalla coscienza universale ha generato la perdita della "coscienza del Tutto" quale unica esistenza felice.
La specie, come dici tu, sarebbe il Tutto?
Quanto alla riflessione di Carlo, certo sulla Terra la Vita sembra autoregolarsi e resistere ai cambiamenti (uno per tutti il paradosso del Sole Giovane). La vita pare sfuggire al principio di entropia.
Di questa vita l'Uomo è senza dubbio parte, non voglio dare un giudizio qualitativo: migliore, peggiore, poco importa.
Ma forse bisognerebbe domandarsi perché l'uomo senta, anziché d'esser parte di un universo vitale l'estraneità della Natura, quindi anche della Vita. L'uomo è l'unico animale (animale è ciò che è dotato di anima, cioè di movimento) che non Vive, ma esiste. Il mio gatto vive, anche il mio cane, ma io solo esisto.
E-sistere significa letteralmente, etimologicamente stare fuori. L'uomo e-siste fuori dalla Natura, fuori dalla Vita potremmo osare di dire. In questa dicotomia sta forse celata la schizofrenia umana, quel continuo apocalittico pensare alla fine. La nostra e-sistenza ha un inizio e una fine, questo è ciò a cui siamo abituati a pensare da secoli. Veniamo dal nulla e torniamo nel nulla questo ci hanno insegnato fin dalla nascita. La nostra esistenza si svolge in mezzo al nulla, tende al nulla.
Ma ciò vale solo per noi uomini, non per la vita. Se domani l'uomo scomparisse, la vita continuerebbe, come continuava prima di noi.
L'uomo ek-siste, l'uomo sta fuori, l'uomo non vive, esiste. Per questo l'uomo ha creato una capanna e poi una polis cinta da mura. Per lasciar fuori ciò che non riconosce come parte di sé, tutto ciò che non afferisce a sé gli è estraneo: il mondo esterno, la Natura, gli altri esseri viventi, animali, pianti, rocce, stelle. La storia dell'Uomo è una storia di muri e di palizzate, alzate per difendersi dall'Aperto, da ciò che sta fuori quelle mura. Il nemico vive fuori.
Oggi la polis è il mondo. Devastiamo il mondo perché lo vogliamo umanizzare, renderlo una sola grande polis. Di questo operato, è chiaro, ne paghiamo le conseguenze. Ed è per mezzo della tecnologia che stiamo riuscendo nell'impresa di umanizzare il mondo.
E dunque, il mio discorso sulla neutralità della tecnica, ovvero sulla sua non neutralità, sul suo essere stato mezzo che si è trasformato in fine, principia proprio da quest'uomo che rifiuta l'Aperto. La tecnica è stata il nostro mezzo, però oggi è diventata così potente da non esser più neutrale, da non esser mezzo. Essa cambia i presupposti, i fini. Perché il fine dell'Uomo è quello di dominare la Natura per proteggersi dalla sua mutevolezza, il fine della Tecnica è il potenziamento senza soluzione di continuità del proprio Apparato di Potere. La tecnica afferma se stessa e, nel farlo, i fini dell'uomo scompaiono.
Mi chiedo, si continuano a costruire armi di distruzione di massa perché servono a difenderci o perché il potenziamento di ogni apparato tecnico è il fine stesso della Tecnica?
Gli animali sanno; l'uomo sa di sapere.
"La nostra e-sistenza ha un inizio e una fine, questo è ciò a cui siamo abituati a pensare da secoli. Ma ciò vale solo per noi uomini, non per la vita. Se domani l'uomo scomparisse, la vita continuerebbe, come continuava prima di noi".
È come dire che a un certo punto dell'evoluzione del mondo Noi siamo capitati sulla Terra impossessandoci di una forma di vita (che poi è diventata il nostro corpo) che, come tutte le altre, ha un inizio e una fine senza toccare la continuità della Natura".
Noi siamo Altro?
"La storia dell'Uomo è una storia di muri e di palizzate, alzate per difendersi dall'Aperto, da ciò che sta fuori quelle mura e "perché il fine dell'Uomo è quello di dominare la Natura per proteggersi dalla sua mutevolezza".
"Il fine della Tecnica è il potenziamento senza soluzione di continuità del proprio Apparato di Potere. La tecnica afferma se stessa e, nel farlo, i fini dell'uomo scompaiono" o, correggo io, rischiano di scomparire se perdiamo il controllo!
I nostri giudizi sono funzionali al mondo e al tempo in cui viviamo quindi certi concetti non hanno mai validità assoluta, ma in questo casino noi abbiamo la facoltà di decidere e mettere un ordine diverso alle cose. Se vogliamo dare un senso alla nostra vita allora guardiamoci in faccia, siamo una sola razza e stiamo soffrendo per nostra stessa colpa.
Diamoci i famosi Dieci Comandamenti e iniziamo a fare i bravi ragazzi. La Bibbia ci racconta come in un'epoca di caos debba intervenire un clima di ferree leggi per evitare che un popolo, un'idea, si dissolva.
Si va un pò troppo a destra o un pò troppo a sinistra ma sappiamo tutti che meglio stare nel mezzo, come nel tuo meraviglioso banco di sardine Giancarlo proteggendosi l'un l'altro.
Questa forse si Namio è fantascienza, ma io sono ottimista per natura. Verrà il momento in cui dovremo scegliere e penso che saremo pronti, d'altronde che altra scelta abbiamo.
Le pulsioni hanno bisogno di essere contentute da una struttura per non portare l'individuo alla distruzione di sé e dell'ambiente che lo circonda. Ecco quindi che l'apprendimento culturale gioca un ruolo fondamentale nell'uomo più che nelle altre specie animali. Noi apprendiamo non per via istintuale, ma per via culturale ciò che è Bene e ciò che è Male. I Dieci Comandamenti, Le Leggi delle XII Tavole, religioni, ideologie, filosofie, Stati, Ordini professionali, chiese e chiesette servono a questo. Ad offrire una struttura alle nostre illimitate pulsioni. Le nostre ferree leggi non sono altro che l'alternativa umana agli istinti.
Non sono ottimista, né pessimista, credo però che l'Uomo debba riflettere in modo serio su chi egli sia e sul posto che adesso occupa su questa Terra.
Anche se con qualche tempo di ritardo, riesumo la discussione fin qui tenuta. Credo che tu, Namio, abbia avuto modo di ragionare a lungo su ciascuno degli elementi che hai raccolto qui, io invece posso cominciare solo a commentare ciascuno d'essi individualmente. Magari, dialogando, anch'io darò a ciascuno il suo peso in questo lavoro.
Nelle citazioni iniziali vai già al sodo: la tecnica modifica l'uomo, la tecnica non è più solo un operare umano (Heidegger). Infatti, l'uomo è oggi guidato dalla complessità dovuta al fatto di vivere in società. Il vivere in società ha generato una serie di paradigmi che tutti, volenti o nolenti, rispettiamo. La società si pone come entità che nella sua complessità indirizza anche la tecnica.
Più volte ho letto citazioni di Galimberti, e spesso penso che scienza, tecnica e metodo scientifico non sono nelle sue corde. Questa volta, con "la tecnica come condizione che decide il modo di fare esperienza" almeno dà una descrizione condivisibile del metodo scientifico.
Quando cominci il tuo pensiero, però, credo che le premesse sono fallaci: l'uomo è tutt'altro che scarsissimo all'adattamento! Quale altro animale senza istinti (non può averne proprio in virtù della sua capacità di adattamento: la cultura è più rapida ad evolversi degli istinti), senza capacità fisiche e motorie, con una prole inetta per decenni, ha popolato ogni continente e ogni clima in… trecentomila anni? Quarantamila? Duole ammetterlo, ma se le grandi estinzioni del passato hanno vaporizzato specie dominanti, l'uomo ha una resilienza senza pari! Anche quando confronti il perfetto adattamento degli altri animali al loro ambiente, trascuri la grande lezione della paleontologia: il perfetto adattamento è la via per l'estinzione, perché un minimo cambiamento dell'ambiente conduce a trovarsi dis-adattati.
Credo che la correlazione felicità-vivere senza tempo sia poco sviluppato: il tempo è l'autentica moneta. Non avere tempo significa non poterne spendere, ma non averne bisogno è l'autentica ricchezza, ma qui si apre un altro discorso sul quale non è il momento di dilungarmi. Nondimeno, apprezzo che anche più giù torni sul tempo, quando osservi che "L'uomo diventa consapevole dello scorrere del tempo, e della direzione del tempo."
Finalmente definisci il mondo nel quale vive l'uomo come creato dall'uomo, "un ambiente a propria misura, solamente suo e di nessun altro." In realtà, quest'ambiente non è dell'uomo, ma della collettività, della società: l'esperimento Utopia (i topi dotati di tutto quanto potessero desiderare) dimostra cosa accadrebbe all'uomo in un mondo "suo", la mancanza di ruoli sociali conduce al suicidio della società mediante comportamenti aberranti, a-sociali.
"La tecnica, il fare, sembra precedere dunque l'intelligenza umana" - vero: molti animali che non riteniamo intelligenti dimostrano di saper fare.
E torniamo a Galimberti, quando fa un parallelo tra tecnica ed etica: "La tecnica apprende le regole della poiesis imitando i processi di trasformazione della Natura, l'etica le regole della misura e dell'ordine a imitazione dell'ordinamento cosmico". È per cose così che non riesco ad apprezzarlo quando parla di tecnica: confonde apprendere con studiare, ed è un errore marchiano, perché se l'etica pone ancora dei limiti (misura e ordine), la tecnica studia per superare i limiti! Tecnica ed etica non sono quindi assolutamente comparabili!
"Tuttavia la scienza moderna [… ] risponde con un: eppur funziona." - MAI! Al limite, questo lo fa la tecnica, ma la scienza, soprattutto quella moderna, non si pone nemmeno il problema se non per valutare la qualità del proprio modello della realtà. La scienza è innanzi tutto FALSIFICABILE (deve potersi dimostrare che quanto afferma è falso), non è MAI verificabile! Obiettivo della scienza è proprio trovare le falle nella propria spiegazione della "realtà", non far funzionare cose o (peggio) le proprie spiegazioni di come funzionano le cose!
"per spiegare come essa fa deve ridurre, e nell'opera di riduzione inevitabilmente l'epistéme rinuncia a com-prendere" - Nel "Signore degli Anelli" il dialogo tra Saruman e Gandalf a proposito del colore bianco è pertinente al riguardo.
"L'incapacità di com-prendere mostra il suo lato debole proprio quando si parla di Uomo e di scienze umane e sociali." - Infatti l'approccio riduzionista (e determinista) in questo caso non funziona. Quello che si sta facendo in molte scienze è accettare la complessità (scienze del caos, l'ultimo Nobel di Parisi in Fisica) e rinunciare al determinismo.
Mi resta poco spazio, proseguo nel prossimo commento.
Qui il tuo discorso si scolla dalla realtà più recente, perché prendendo le mosse di Heidegger mette a fuoco l'accumulo dell'energia. Ma dal dopoguerra il capitalismo ha deposto l'accumulo come alcunché di negativo (genera costi) sotto ogni suo aspetto (il casopiù evidente è l'economia del debito). La globalizzazione ha fatto credere che l'accumulo non fosse necessario nel tempo, ma che potesse essere spostato nello spazio (produco altrove e trasporto da lì solo ciò che il mercato richiede).
Il sistema è crollato alla minima crisi: energetica (petrolio anni '70), finanziaria (subprime 2008 ), sanitaria (Covid 2019 e Sars di minore entità qualche anno prima), bellica (Ucraina).
Quindi i paradigmi economici, che ormai di tecnico non hanno più niente perché rifiutano in virtù dei dogmi finanziari di essere sottoposti ad analisi critica, hanno minato alla base i fini della tecnica. L'economia, non la tecnica è diventata l'ultimo orizzonte dell'uomo ma, non essendo compreso nei suoi modi, resta pura aspirazione, è un orizzonte velleitario!
Quando più sotto sembri equiparare comunismo e marxismo/socialismo, anche su questo discrepo, e non solo perché sono molto diversi, ma perché in realtà nessuna di queste idee ha mai trovato la sua realizzazione!
Quindi anche il confronto col capitalismo crolla: il capitalismo non è più idoneo "a rendere congruenti le proprie aspettative a quanto viene richiesto per il funzionamento ottimale dell'Apparato", semplicemente attraverso le spinte incoerenti connaturate a sé stesso (la pluralità di desiderata dei diversi attori sulla scena economica) esso ritarda la propria implosione. Ma manca poco: pochi nomi (Musk, Amazon, Google) stanno diventando i monopolisti del mondo, e questo farà crollare il castello come non si riesce ancora a immaginare.
Persino Severino emette una predizione ottimista ("Il capitalismo, guidato da un impulso irrazionale come l'avidità, prima o poi metterà in pericolo la sussistenza dell'Apparato tecnico scientifico e sarà da questo sostituito."). Le parole "irrazionale" e "avidità" denotano un giudizio etico e non un'analisi razionale di ciò che accadrà.
Mi ha colpito l'espressione "razionalità tecnica". Credo che "etica tecnica" sia più indicato a esprimere il concetto che l'ecoambientalismo cerca di seguire.
È sottile la valutazione sulla scienza: "La verità scientifica". Non esiste niente del genere: la scienza è un metodo, non un dogma. Non può avere verità qualcosa che deve essere per definizione falsificabile, che è un modello riduttivo e approssimato (altro grande attributo della scienza qui per niente nemmeno sfiorato).
Io spero. "L'accumulazione del denaro" come "unico metro a disposizione" è un'imposizione occidentale, e fortunatamente (a seconda dei punti di vista) molti Paesi del mondo stanno lasciando l'indigenza, cominciano a esportare le loro idee. Io spero che qualcuno abbia l'idea che permetterà al mondo di non finire divorato dall'irrazionale avidità della City e di Wall Street, e potrebbe essere un'idea che userà la tecnica e la scienza. Certamente userà l'etica.
L'auspicio è un invito a non fermarsi sulla soglia, a entrare in casa. La casa è costituita da un pensiero altro rispetto a quello in cui si agita il dibattito quotidiano: un invito ad ascoltare, a metter da parte i preconcetti. Impresa ardua.
Esordisco con una premessa: il termine tecnica, dal greco techné, è un termine filosofico non assimilabilie all'italiano tecnica o tecnologia, ma ad episteme, ossia il termine identidica un insieme di conoscenze, di principi. La tecnica include perciò le scienze esatte economia compresa e le tecnologie ma non è propriamente un loro sinonimo. D'altra parte la il termine indica anche un'attività concreta volta alla costruzione, alla fabbricazione.
La tecnica è moderna o antica, perché l'idea di episteme non esisteva nel mondo antico, dove la scienza è theorìa, ossia contemplazione (da thea orao, guardare uno spettacolo e perdonami se traslittero in caratteri latini). Mentre la tecnica moderna è guidata dal metodo sperimentale.
La questione della tecnica è il tema di una conferenza tenuta da Heidegger quasi settanta anni or sono ed è forse l'opera più citata di quella che io ritengo la più grande mente pensante degli ultimi secoli. Nella conferenza affronta il tema della tecnica, come episteme, che si trova un po'ovunque nella sua opera principale: Essere e Tempo. Heidegger prova a impostare un pensiero innovativo capace di oltrepassare "la definizione strumentale e antropologica della tecnica" ovvero l'idea che essa sia solo un MEZZO e un'attività dell'uomo.
Per Heidegger la tecnica non è mera poiesis, puro fare, ma un modo del disvelamento. La tecnica permette di svelare le forze della natura per lavorarle, mutarle. Ma se la tecnica antica è essenzialmente (ma non esclusivamente) produzione, è legata a una qualsiasi forma di produzione, quella moderna ha una funzione provocativa. La provocazione consiste nel disvelare le forze che abitano la natura per trasformarle e soprattutto immagazzinarle. Con la tecnica moderna il mondo intero diventa un fondo a disposizione dell'uomo.
Sono andato ad ampi passi e avrò tralasciato qualcosa, porta pazienza. Il testo della conferenza è breve e molto facile da leggere se vuoi.
Quanto al pensiero di Jaspers e Anders sull'uomo come animale non dotato di istinti. Hai ragione, l'uomo si adatta ad ogni ambiente, ma non certo grazie al suo apparato fisico o istintuale, ma in virtù dell'apprendimento culturale. Su questo non siamo in disaccordo. Ma è la povertà di istinti che ci ha condotto verso l'apprendimento culturale? Io credo che l'uomo abbia rinunciato agli istinti che di certo aveva un tempo più d'adesso perché l'apprendimento culturale è più efficiente, tutto qua.
Quanto all'etica, come la religione o le ideologie o il diritto, essa è la struttura culturale che ha tra gli altri fini quello di contenere le pulsioni in cui si sono trasformati gli istinti umani. Le pulsioni, a differenza degli istinti, sono indeterminate e illimitate, perciò è necessaria una gabbia per non farle esplodere, quale essa sia. Non solo, ma soprattutto essa è, come la religione o l'ideologia, un modo del dis-velamento.
Etica e tecnica sono equiparabili, come la religione o le ideologie, perché entrambe sono un modo del dis-velamento della natura.
La forza della scienza sta nella falsificazione scrivi: certo, lo sostengo anch'io, sia chiaro. La scienza moderna smentendosi si autoafferma, mentre le altre forze della tradizione occidentale smentendosi svanirebbero. Una forza dirompente mi pare.
Quanto all'accumulazione, una delle tesi di Heidegger è quella che il mondo sia divenuto un fondo a disposzione dell'uomo. L'uomo immagazzina risorse, accumula capitali. E quanto al capitalismo (che, bada bene, non è uno dei modi della tecnica ma l'ultima forza della tradizione) tu stesso mi pare ammetti che abbia come suo ultimo fine l'accumulazione di valore senza fine. L'economia del debito forse non va più di moda ma mi pare che tutti, stati e individui, siamo indebitati fino ai capelli. Ma ahimé questo è un altro discorso. Ti scrive un vecchio comunista.
Quanto all'economia, essa è invece un modo della tecnica (e non è una contraddizione), non una forza della tradizione. Il pensiero economico è una delle forme del pensiero tecnico. Il suo apparato è un apparato tecnico. Se la politica (e la democrazia) perde senso è perché le decisioni vere e fondanti sono prese da quell'apparato tecnico economico non eletto e quindi non democratico. La tecnica vince sulla politica, perché l'unica forma di legittimazione oggi rimasta è quella della razionalità tecnica e degli apparati che la servono. Lo dice l'Europa è solo un modo per dire che esistono ragioni tecniche che prescindono dalle ragioni di chi si trova al Governo. Ragioni non emendabili dalla politica, sottratte alle regole del consenso, che sfuggono a ogni dibattito, a ogni ricerca di un fine che vada
Il mezzo è diventato il fine.
avevo anticipato che avevo bisogno di "collocarmi", prima di sapere di cosa parlavamo.
Hai chiarito che la "tecnica" della quale parli tu (e Galimberti, a questo punto) è altra cosa rispetto a quello che si intende comunemente. Non apprezzo molto questo genere di ambiguità linguistiche, e apprezzo che tu abbia usato spesso il greco techné, eventualmente integrato da epìsteme, perché così ogni cosa è al suo posto.
Il succo (volendo spremere il discorso all'osso) è che in un mondo dove le "macchine" se la cantano e se la suonano, non c'è posto per l'uomo. Nulla da eccepire sulla conclusione, che trovo corretta partendo da questi presupposti. Anche l'obiezione "ma ci sarà sempre un uomo che dirà alle macchine cosa fare" la trovo pretestuosa: non sarà "l"'uomo, ma "un" uomo, una pedina dell'Apparato, un super-specialista nel proprio campo (un tecnico) che non prende decisioni ma esegue ciò che altri "tecnici" (e qui mi riferisco a operatori economici e/o politici) gli dicono di fare. Nella nostra società e nel nostro Apparato culturale/intellettuale/produttivo la presa di decisioni è sempre più distante da coloro che le mettono materialmente in pratica.
Di fatto il potere ha capito di non potere, di NON VOLERE fare le due cose allo stesso tempo: dichiarare la guerra e combatterla, mandare uomini sulla Luna e andarci, organizzare la distribuzione di mercanzie a livello mondiale e condurre i furgoni che quelle mercanzie smistano. Chi ha il potere vuole godersi il frutto dell'attività di altri, subalterni, sottoposti, i "miei cari inferiori" anche col pezzo di carta.
Eppure, nel tuo uso di techné, anche chi ha potere è "tecnico", applica una disciplina "tecnica". Nella semplificazione di voler ficcare ogni materia alla quale si applica un metodo nella parola "tecnica" (quindi anche la filosofia, anche l'etica, visto che tu chiami l'economia una scienza esatta… ), senza tenere conto delle profondissime differenze tra l'una e l'altra, inevitabilmente ci perde l'uomo.
Quando Heidegger 70 anni fa dà la sua conferenza era vivida l'immagine di Hiroshima e Nagasaki rase al suolo dall'atomica. La sua Germania, risparmiata dagli Alleati, era stata sotto il nazismo e continuava a essere fabbrica, ininterrotto opificio, nel quale l'abbrutimento dell'operaio era più che tangibile. La sua critica a questo mondo "vincente" è trasparente, ma non può esprimersi con maggior precisione e resta a puntare il dito contro un vago e non più corrispondente al senso attuale "tecnica". Inutile denunciare un crimine, sapendo chi è il criminale, se non si ha il coraggio di denunciare il criminale.
Perché è fallace il "calderone"? Perché "tecniche" diverse usano strumenti, metodi, impostazioni, assiomi, FINI diversi.
Cominciamo dalla scienza (scientia). Il suo fine è la conoscenza (scientia) stessa. Personalmente usavo molta tecnica nell'università, ma il fine era la scientia. Ti dirò, almeno lo scienziato pensa che sta facendo qualcosa PER l'umanità (ho contribuito a realizzare macchine per la rivelazione precoce del cancro… )
Lo stesso accade con l'economia: un operatore economico e finanziario punta all'accumulo di denaro. Dubito però che lo faccia pensando al bene dell'umanità. Certamente lo fa pensando al bene dell'azionista, dal quale proviene la sua paga. Questo, in un mondo capitalista, significa fame e sfruttamento per altri, molti altri, in qualunque parte del mondo.
Inoltre, dovresti leggere i testi di economia attuali per capire che da tempo l'economia non è più techné, né scienza (in quanto a essere "esatta", poi… ), ma piuttosto un bignami di tecnicismi che assomigliano molto a parole d'ordine messe lì per far inginocchiare il volgo e giustificare qualunque nefandezza.
Dove voglio arrivare? Il fine di qualunque scientia è la scientia stessa (ho avuto modo di riflettere che chiamiamo le persone in base a ciò che studiano), ma è importante stabilire il rapporto tra questo fine e l'uomo che, per ciascuna disciplina è diverso.
Perciò, la tecnica è diventata fine a sé stessa? Ok l'episteme, ma non scopri niente (oggi) quando dici così. Più mi preoccupa il non relazionare il fine con l'uomo, il non distinguere tra disciplina e disciplina, perché in una critica generalizzata si perderà di vista la responsabilità di ciascun attore.
E ora scusa, ho gettato troppa carne a cuocere e vorrei chiarire molte cose. Questa è la mia prima impressione.
user deleted
Secondo il filosofo, per accedere all'essenza della tecnica, intesa come techné, non possiamo limitarci a considerare i singoli e diversi strumenti tecnologici, ma è necessario accostarsi alla questione con un rinnovato spirito critico. Si tratta in altre parole di mettere da parte ciò che si sa e trovar il coraggio di fare un balzo nel vuoto rispetto alla tradizione, d'instaurare con l'oggetto di studio un "relazione libera" da vincoli, proponendo una diversa e nuova cornice ontologica. È a questo punto che Heidegger comincia con il chiedersi quale sia l'essenza della tecnica:
La tecnica non si identifica con l'essenza della tecnica. (…). Non possiamo quindi esperire veramente il nostro rapporto con l'essenza della tecnica finché ci limitiamo a rappresentarci la tecnicità e a praticarla, a rassegnarci ad essa o a fuggirla.
Ogni risposta che chiama in gioco la responsabilità dell'uso di una determinata tecnologia, o ogni teoria filosofica che preveda di gestire il potenziale tecnico grazie alla sempre crescente abilità umana di ragionare e prendere giuste decisioni, per Heidegger va abbandonata in quanto ignora la capacità "mitopoietica", ri-costruttiva, della tecnica di alterare le condizioni di creazione del significato e del valore delle azioni.
L'essenza della tecnica non ha nulla a che vedere con lo strumento o processo tecnologico. Secondo Heidegger, la tecnica è essenzialmente un modello di conoscenza, una particolare modalità di rivelazione di ciò che è.
La tecnica è il modo di leggere e capire il mondo, nella tecnica l'uomo prende parte, seduce il mondo ovvero fonda uno schema di referenze che costituiscono la maniera nella quale gli oggetti vengono alla presenza. Il modo in cui le mere cose ci si presentano influenza il modo umano di impegnarsi con il mondo.
Con la tecnica il pensiero si fa aggressivo perché rende ogni presenza, incluso l'uomo, un oggetto da manipolare, ogni ente uno strumento da valorizzare e impiegare, un Bestand. La tecnica, come scrivevo, pro-voca la Natura, nel senso che esige da essa energia che possa essere estratta e accumulata. Ogni cosa è così immediatamente "pronta per l'uso" e ha valore fintantoché è utilizzabile.
Secondo Heidegger, l'agire tecnico è l'ultimo gradino del progetto occidentale di dominio sulla natura e del suo sfruttamento che ha reso il bosco una riserva di legname, la montagna una cava di pietra e il fiume una forza idraulica per produrre elettricità:
Nell'ambito di questo successivo concatenarsi dell'impiego dell'energia elettrica anche il Reno appare come qualcosa di "impiegato". La centrale idroelettrica non è costruita nel Reno come l'antico ponte di legno che da secoli unisce una riva all'altra. Qui è il fiume, invece, che è incorporato nella costruzione della centrale.
Il pensiero che conosce il mondo come una riserva è instaurato dal Gestell, o impianto (nella terminologia di Foucault, l'impianto lascia il posto a Dispositif o Apparatus come segnalato di recente da Agamben).
Secondo Heidegger infatti la tecnica non lascia esser le cose in quanto tali, non le rivela per quel che sono. Invece di lasciar esserle nella loro "vicinanza" le provoca, le costringe alla presenza, attraverso il processo di oggettivazione. Ma quest'oggettivazione non avvicina gli enti tra loro bensì rende ogni cosa un oggetto da afferrare, calcolare e controllare.
Così gli strumenti di trasporto e i mezzi di comunicazione permettono alle persone di coprire lunghe distanze in poche ore oppure di veder trasmessi gli avvenimenti del mondo nello schermo della televisione nella propria stanza da letto non fa che rendere ogni cosa indistinta in quanto tutto non è niente se non è utilizzabile.
La tecnica non lascia nemmeno essere l'uomo che, come ogni altro ente nel mondo, è individuato e ordinato dal dispositivo, dal meccanismo, dalla griglia a rete del procedere tecnico. Nella modernità l'agire dell'uomo non ha più scopo proprio perché l'ente non è più in quanto ente ma funziona in quanto eterodiretto, connesso originariamente ad altro.
La tecnica è quindi per Heidegger "un significato e un'attività umana", un particolare tipo di razionalità che nel corso della modernità ha fagocitato e assimilato ogni altro precedente modo di pensare, e reso mondo e uomo a una dimensione (H.Marcuse, L'uomo a una dimensione, 1964). Questa razionalità che è pensiero e agire, concepisce la realtà come una macchina, come meccanismo ininterrotto dove tutto funziona per realizzare sempre un più complesso ed efficiente funzionamento.
Nell'età della tecnica l'uomo non si chiede più il senso dell'essere e la terra gli si fa estranea.
Quando il filosofo suggerisce che l'uomo è un "essere gettato nel mondo" ci sta dicendo che l'individuo (o soggetto), che la tradizione ha da lungo pensato come autonomo, indipendente e già in sé teologicamente orientato alla soddisfazione dei propri fini e bisogni, non è affatto tale.
Heidegger è tra i primi a riconoscere che la tecnica non è semplicemente umana né completamente inumana ma è lo sfondo che genera entrambi, in questo senso Gestell è originario sia all'uomo sia al materiale, al mondo. Essendo il fiume Reno "incorporato" e quindi impiegato dal dispiegamento della tecnica, quest'ultima è già da sempre potere.
Tecnica, apparato, dispositivo, meccanismo, protocollo, struttura, rete sono infatti i molti modi di chiamare quel potere che non è umano né non-umano, un potere decentrato, ubiquo e continuo che funziona se e solo se è in grado di far sistema e fagocitare in sé tutti gli altri enti ovvero di individuarli e farli essere.
Dal punto di vista del potere, tecnica e rete risultano inseparabili tanto che ogni tecnologia è in sé stessa una rete quasi-finita di relazioni ordinate e regolate dal potere stesso della rete e poiché, la questione della tecnica è antica quanto il dominio dell'uomo sul fuoco, la rete non può più venir pensata come la moda del nuovo millennio ma come argomento degno di indagine filosofica.
Heidegger sembra già aver chiaro che non è possibile pensare la tecnica – e quindi il potere nella complessità della rete – come l'azione o il pensiero di un solo attore. Allo stesso modo non è possibile cogliere la proprietà della rete a partire dalla somma delle proprietà dei suoi costituenti né, viceversa, questi ultimi come parti di un tutto.
Il potere della tecnica non agisce attraverso azioni violente e determinate ma ciononostante è capace di ordinare, regolare e individuare le connessioni, gli scambi d'informazioni e le azioni delle componenti individuali. È un potere totalitario ma decentrato, continuo ma discreto, individuante e dissociante. Per alcuni versi in modo simile a Heidegger, secondo Foucault la società è da sempre regolata da meccanismi di potere / sapere che garantiscono la produzione e il controllo di relazioni asimmetriche tra gli individui. Nella società moderna questi meccanismi assumono il modello chiamato Panoptico.
Il totalitarismo non è che la manifestazione del pensiero tecnico in politica, dove alla rappresentanza e alla discussione tra pari in vista di un accordo fondato sulla ragione degli argomenti è sostituito un apparato amministrativo il cui unico fine è il perpetuamento e la soddisfazione di sé stesso.
Heidegger è convinto che il maggior pericolo sia dovuto alla progressiva uni-dimensionalità della ragione che fa del pensiero e agire tecnico l'unico e il solo modo di stare al mondo dell'uomo.
Del resto, il processo di oggettivazione che rende ogni ente, compreso l'uomo, uno strumento in vista di un fine, non è diverso dal movimento a questo opposto che costituisce l'individuo come soggetto di volontà sul mondo. Tale processo è chiamato soggettivazione.
Questi due processi, che apparentemente procedono per opposte direzioni, sono in realtà diversi punti di vista del medesimo meccanismo di individuazione, che fa apparire e scomparire gli enti dal mondo, i nodi dallo sfondo della rete.
L'argomento di Heidegger è dunque la parte destruens di una filosofia della tecnologia che non intende scadere del determinismo tecnologico o della potenza incontrollata e sublime dell'uomo sul mondo. Ciò nonostante, sono il primo ad ammetterlo, il suo pensiero ci dice poco o nulla circa possibili altre vie praticabili. Heidegger pone la questione, non la soluzione.
Ma già comprendere che vi è una questione della tecnica sarebbe un gigantesco passo in avanti.
La tecnica ci induce a pensare e a porci verso il Mondo in un determinato modo. Nel tuo intervento parlavi di economia. È una scienza sociale, come si usa dire oggi con un brutto termine. Quasi che senza scienza sia negata ogni forma di conoscenza. Tuttavia l'economia ha scelto proprio la razionalità tecnica non solo per rappresentare se stessa, ma soprattutto per legittimarsi. L'economia deve procedere con l'armamentario del metodo scientifico, deve proporsi come una scienza diretta da metodo scientifico, perché l'unico orizzonte possibile è quello della tecnica.
Il fine ultimo della scienza non è la conoscenza, caro Marino. Lo era nell'Antica Grecia. Ma oggi il fine ultimo è la manipolazione della natura, la reificazione dei viventi, la produzione e l'accumulazione di energia, e quindi di potere. In poche parole la propria autoaffermazione.
ho seguito quanto raccogli di Heidegger che, nella sua crudezza, descrive le cose esattamente per quelle che sono, ma mi pare che ci sia un errore di impostazione, si percepisce dall'angoscia nel descrivere il mondo per come funziona: la tecnica tende alla reificazione dell'uomo.
La tecnica se ne frega, dell'uomo, in quanto tale. Per la tecnica l'uomo è solo un altro accidente! Crearsi il problema di come la tecnica si pone nei confronti dell'uomo è il vero limite intellettuale di tanta filosofia.
Ho appena terminato di chiarire la cosa a Gabriele in termini simili al riguardo della religione: la scienza non si chiede il perché delle cose, ma solo il come. Preoccuparsi che la tecnica reifichi l'uomo significa chiedersi: "Ma allora la tecnica non si pone un problema morale di cosa fa all'uomo?", e la risposta è, brutalmente, "NO", ed è persino giusto così.
Ma nell'angoscia del porre la domanda quel "NO" viene recepito come un "allora tu, tecnica, VUOI la reificazione dell'uomo!", e la risposta è la stessa: "NO".
La tecnica non se ne po' frega' dde meno.
Perciò per me è così importante la distinzione tra discipline, e in particolare con l'economia. Quando scrivi
"È una scienza sociale, come si usa dire oggi con un brutto termine. Quasi che senza scienza sia negata ogni forma di conoscenza. Tuttavia l'economia ha scelto proprio la razionalità tecnica non solo per rappresentare se stessa, ma soprattutto per legittimarsi. L'economia deve procedere con l'armamentario del metodo scientifico, deve proporsi come una scienza diretta da metodo scientifico, perché l'unico orizzonte possibile è quello della tecnica."
dici cose estremamente opinabili. L'economia ha scelto la razionalità tecnica per RAPPRESENTARE sé stessa, ma di razionale e tecnico in essa c'è assai poco: le conoscenze matematiche e statistiche degli economisti sono a dir poco risibili; l'epìsteme, da te più volte citata come punto di svolta nella praxis della tecnica, è totalmente BANDITA dal campo dell'economia; i libri di testo delle facoltà di economia attualmente riportano UNICAMENTE le teorie (nota: teorie, proprio perché non esiste epìsteme) liberiste, ovvero quelle che hanno condotto alla catastrofe dei subprime nel 2008.
È noto l'episodio di Elisabetta che, proprio dopo la catastrofe dei subprime, andò alla City a farsi spiegare cosa fosse accaduto. Voglio dire: sei la sovrana di una delle borse più importanti del mondo, che ha appena dimostrato di non capire una beneamata mazza di quello che è il mondo reale, un cazziatone a quel Dio biondo è il minimo! Nessuno seppe spiccicare parola.
Il fine ultimo della scienza è ancora oggi la conoscenza, caro Namio, come lo era nell'Antica Grecia. Perché quando parli di "fine", parli di volontà e di persone, e l'operatore, lo scienziato, non fa quello che fa per reificare chicchessia.
La manipolazione della natura, la reificazione dei viventi, la produzione e l'accumulazione di energia, e quindi di potere, sono obiettivi da ricercarsi in altre stanze, che con la tecnica hanno assai poco a che vedere.
Ma ti pare che a uno scienziato non piacerebbe trovare il modo di salvarlo, questo pianeta, per sé, per i propri figli, per l'umanità intera? Non sarebbe bello lavorare per qualcuno che mette denaro nel trovare fonti di energia che rispettano il pianeta? Senza costringere i bambini dell'Africa a ficcarsi sotto terra per estrarre il coltan? È la scienza, o la tecnica, che stabilisce qual è lo scopo di una determinata ricerca per la quale la tecnica è solo strumento?
Se parli di "fini", allora non puoi trascurare che nell'espressione "fine a sé stessa" indichiamo la mancanza di ogni altro scopo se non la propria sussistenza e il proprio progresso, e certamente non intendiamo la reificazione di alcunché. La tecnica è un metodo, non un fine, e a me pare siano cose diametralmente opposte: la reificazione è necessaria per lo studio, il cui fine tecnico resta la conoscenza dell'oggetto.
Cerca, perciò, (con Heidegger e Galimberti) i responsabili della tragedia che si è abbattuta sull'uomo tra chi ha come fine, come obiettivo detta reificazione.
Soluzioni? Io credo esistano, e vengono da maggior cultura, maggior istruzione, DIVERSA istruzione (che punti alla crescita dell'uomo come individuo cosciente di sé in seno a una società sana). La soluzione deve partire dal basso, dall'uomo stesso, dall'affermazione dell'uomo.
Quanto all'economia, mi pare ci stiamo un po' incartando. E mi pare che tu le rimproveri di non essere proprio ciò che essa disperatamente prova ad essere: una scienza diretta e sostenuta dal metodo sperimentale. Solo in esso risiede la verità che deve essere di volta in volta smentita per affermare la propria veridicità.
Non sto scaricando le responsabilità di molte nefandezze su altri, ma così funziona questo mondo dal di dentro, e di esempi ne ho a bizzeffe; molti, personali.
Ho partecipato allo sviluppo di una macchina per la rivelazione precoce del cancro: cancro alla mammella. Una macchina rivoluzionaria al tempo e ancora oggi: una dose di raggi X ridotta del 95% (immagina la sicurezza e la mancanza di controindicazioni) e una qualità delle immagini 3/4 volte migliore di quelle in commercio (15 anni fa). Ricerca derivata dai rivelatori del CERN, costi irrisori per la produzione. Non si trovò UNA casa che volesse produrla perché i produttori dovevano ammortizzare i costi delle LORO ricerche con la vendita di macchine meno efficienti.
In Italia ho partecipato allo sviluppo di un dispositivo di Realtà Aumentata (si fa presto a dire "occhialini") da usare come guida museale interattiva (capiva il parlato, poteva rispondere alle domande del visitatore, e si portava in un borsello), superiore per diversi aspetti al tanto vantato Oculus oggi usato da Meta, ma il progetto era finanziato dal ministero che ha pagato l'ultima tranche 18 mesi dopo il termine…
Capisci se me la prendo così con l'economia: una scienza economica sana investirebbe l'impossibile in progetti per migliorare la vita dei cittadini, dei pazienti, in ogni modo possibile. Lo farebbe per sé stessa, perché la ricerca ha un ritorno sull'investimento mediamente superiore al 400% (ti sottolineo "mediamente" che include la CATERVA di progetti fallimentari). Lo farebbe per i cittadini perché chi vive in migliori condizioni, con mezzi migliori, e si ammala di meno, è un cittadino che produce di più e genera maggior produttività.
Ero ancora in Italia, fui contattato da un milionario (in euro) che voleva (a suo dire) sottopormi un progetto di ricerca per il suo "business": energia solare. Si accomodò con la giacchetta figa, le due segretarie giovani, l'ultimo iPhone sul bracciolo di una poltrona e le chiavi della Porsche Cayenne sul bracciolo dell'altra. Nel suo business, mi spiegò, sarebbe stato "un vantaggio competitivo avere accesso a una tecnologia più avanzata per lo stoccaggio dell'energia". Era disposto a "investire" diecimila euro per ottenere un simile vantaggio. Gli esplosi a ridere in faccia: il tipo era disposto a spendere non so quanto per andare in giro in Cayenne, ma per ottenere il "vantaggio competitivo" dal quale dipendeva il permettersi il Cayenne, avrebbe "investito" diecimila euro!
Ma la mia risata era dovuta ad altro: lo stoccaggio dell'energia sono ovviamente batterie, e lui usa le Zinco-Carbone per i volumi di energia che accumula, che rapidamente invecchiano coi cicli di carica e scarica. Alternative ce ne sono, e il tipo sembrava non aver mai riflettuto sul fatto che nel suo iPhone ci fosse una simile alternativa. Glielo feci osservare, e gli feci osservare che quella tecnologia era il frutto di decenni di voli spaziali e di MILIONI di euro spesi da Apple e Samsung per migliorare le tecnologie esistenti (metalli, idruri di litio, etc.). Ma lui voleva una ricerca con diecimila euro…
Perciò, l'economia può MILLANTARE di essere una scienza quanto vuole, ma è e resta quella cosa sulla quale Brunetta e Tremonti possono andare in TV a litigare sul senso della derivata seconda del PIL (accadde qualche anno fa), mentre il mondo è totalmente sfuggito di mano. Non uso il termine a caso: TUTTA l'economia usata (ci sono, invero, STUDI che si discostano da questo modello, ma restano studi marginali e ipotetici dei quali nessuno vuol sentir parlare, anche perché spesso i risultati contraddicono i paradigmi attuali) nel mondo è "analisi dello stato stazionario" (equilibrio tra produttori, consumatori e risorse). Descrivere qualcosa di fluido come l'economia con quel tipo di analisi mina alla base qualunque credibilità della disciplina.
Ma se proprio ora, con Draghi al governo (uno che ne dovrebbe capire), le milionarie risorse del PNRR avute dall'UE vengono stornate per spese belliche (altro debito), le tasse che non potevano essere ridotte ai cittadini lo sono alle industrie belliche che proprio ora stanno stravendendo, come puoi dirmi di considerare una techné dotata di epìsteme l'economia?
Sono tornato in Spagna con un progetto UE per l'assorbimento di ricercatori nell'industria: fanfara e (credo) 2 milioni di investimento per 50 progetti. Poi scoppia la guerra in Ucraina e la Germania spende MILIARDI in armi! E alla Grecia hanno tolto i denti per mangiare!
No, grazie! Potranno avere il Cayenne e andare a cena col vescovo, e lì si dimostrano per quello che sono: un'altra potente setta fideistica. La tecnica e la scienza sono altro.
E non era neanche impossibile prevederlo. Nella sua scarna, disarmante lucidità Eschilo aveva già compreso nel Prometeo incatenato dove si sarebbe potuti andare a finire. Una pre-visione di duemicinquecento anni or sono, quando oggi non riusciamo ad alzare lo sguardo neanche di cinque anni.
user deleted
Scrivere recensioni e commenti alle opere è uno dei motori principali di questo portale artistico. È solo grazie a esse che, infatti, gli autori possono migliorarsi e i visitatori orientarsi. Se sei un autore, inoltre, scrivere recensioni e commenti a opere altrui incentiverà i destinatari a fare altrettanto con le tue.
Nota: le recensioni e i commenti devono essere lunghi almeno 30 battute e devono riguardare il contenuto dell'opera, meglio se critiche, costruttive e collaborative. Saranno eliminate dallo Staff le recensioni se saranno: offensive, volgari, chiacchiere e (se scritte da visitatori) presunte autorecensioni dell'autore o banali "bello, mi è piaciuto".
Nota: le recensioni e i commenti sono tuoi e modificabili per 2 giorni, dopodiché diventeranno di proprietà dell'autore che hai recensito o commentato.
NO JAVASCRIPT
NO BUTTON
Nota: per vedere un'opera a caso di un particolare genere, entra nell'elenco dei generi e scegli la tipologia desiderata.
Questo indirizzo email è protetto dagli spam.
Attiva JavaScript per vederlo. eventuali termini o contenuti illeciti, scurrili o errati che potrebbero essere sfuggiti al controllo degli Autori o dello Staff.





 pubblica tua opera
pubblica tua opera